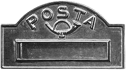Bibliografia - Scritti minori
Abbreviazioni
AASV = “Atti dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona”;
Ar. = quotidiano “L’Arena di Verona”, in seguito “L’Arena”;
CT = rivista semestrale “Cimbri/Tzimbar”, Verona;
IP = rivista “Il Polo”, Civitanova Marche (Macerata) e in seguito Fermo;
LVS = notiziario mensile “La Voce Socialista” del PSI di Villafranca, Villafranca di Verona;
Mar. = notiziario mensile “El marciador” del Gruppo Marciatori Mondadori, Verona (dal 2000 divenuto “Il Marciatore dello Sporting Club Mondadori”);
QP = rivista “Quadrante padano”, Mantova;
RIOn = rivista semestrale “Rivista italiana di onomastica”, Roma;
SVE = periodico “La solidarietà di Verona Est”, Gruppo Promozionale Borgo Trieste, Verona;
TC = rivista trimestrale “Terra cimbra”, Giazza (Verona);
VV = rivista bimestrale “Vita veronese”, Verona.
1. Lettera a VV, pubblicata nel n. 9-10, 1966, col titolo Sulle “Questione de lingua veronese”, per chiedere lumi sui popoli che precedettero i Romani nel Veronese. La lettera occupa le pp. 379-380; a essa risponde G. B. Pighi, nelle pp. 381-382.
2. Da Recoaro - in TC n. 31, 1977, pp. 19 e 28.
A pag. 28, mezza pagina è dedicata a note linguistiche relative a due espressioni cimbre e a una veronese (di canti popolari).
3. Da Recoaro: incontri culturali - in TC n. 32, 1977, pp. 37-38.
4. Recensione di: Diego Poli, Protostoria, lingua e cultura nell’area del Mare del Nord (Parte Prima, Napoli 1975; Parte Seconda, Napoli 1976) - in IP n. 1, 1978, pp. 45-46.
5. I cognomi cimbri - in “La Lessinia - ieri oggi domani”, Quaderno Culturale 1978, pp. 27-30.
Semplice elencazione dei principali cognomi cimbri dei XIII Comuni, che non si addentra nelle singole etimologie.
6. Traduzione di sei lettere scritte dal prof. Schnetz a mons. Cappelletti e concernenti la toponomastica dei XIII Comuni, pubblicata sotto il titolo Un’interessante corrispondenza in TC n. 35, 1978, pp. 18-20.
Si tratta di lettere scritte dallo Schnetz nei primi tre mesi del 1935.
7. Precisazione sull’etimologia del cognome Rubele (per il quale si veda il § 11 di “Articoli”) in TC n. 36, 1978, pag. 13.
8. Precisazione in merito a un saggio di Luigi Onestinghel del 1912, in TC n. 36, 1978, pag. 13.
9. Recensione di: David McC. Grubb, A Practical Writing System and Short Dictionary of Kwakw’ala (Kwakiutl), 1977 - in IP n. 3, 1978, pp. 125-126.
10. Recensione di: Lawrence R. Smith, Some Grammatical Aspects of Labrador Inuttut (Eskimo): A Survey of the Inflectional Paradigms of Nouns and Verbs, 1977 - in IP n. 3, 1978, pp. 126-127.
11. Curata la traslitterazione delle voci cimbre nel volume di Eligio Faggioni Iz jar kan Ljetzan / L’anno a Giazza, Curatorium Cimbricum Veronense, Verona 1979.
12. Recensione di: Diego Poli, Protostoria, lingua e cultura nell’area del Mare del Nord (Parte Terza, Napoli 1977) - in IP n. 1, 1980, pp. 26-27.
13. Recensione di: Alex Spalding, Learning to Speak Inuktitut: A Grammar of North Baffin Dialects, 1979 - in IP n. 3, 1980, pp. 89-90.
14. Traduzione del saggio di Wilhelm Baum Deutsche Sprachinseln in Slowenien (= Isole tedesche in Slovenia) in TC n. 43, 1980, pp. 23-35.
15. Recensione di: Giovanni Solinas, Storia di Verona, Verona 1981 - in: “La Lessinia: ieri oggi domani - Quaderno culturale 1982”, pp. 245-246.
16. Bartolomeo Rubele era un imbroglione - articolo nel settimanale “Il mattino di Verona” del 9 aprile 1982.
17. Clocègo: origine di un nome - articolo nel settimanale “Il mattino di Verona” del 9 aprile 1982.
18. Le parlate del Baldo - articolo nel settimanale “Il mattino di Verona” del 7 maggio 1982.
19. Cosí a Verona l’“ebreo errante” trovò pace nel ghetto del 1604 - prima parte di un articolo la cui seconda parte è riportata qui sotto col § 20, nel settimanale “Verona fedele” del 23 gennaio 1983.
Una succinta storia del Ghetto di Verona.
20. Gli ebrei nel Veronese: cacciati anche da Verona trovarono rifugio a Soave - seconda parte di un articolo la cui prima parte è riportata qui sopra col § 19, nel settimanale “Verona fedele” del 30 gennaio 1983.
Si accenna qui alle altre comunità ebraiche del Veronese.
21. Lettera ad Ar. del 23 marzo 1984 sull’etimo del nome Schermenzareick di Legnago (Verona).
22. Lettera ad Ar. del 21 aprile 1984 sulla grafia esatta di Bad’ ’e Carros, toponimo della Sardegna.
23. Lettera ad Ar. del 3 agosto 1984 su un’iscrizione in un volto del Tribunale di Verona risalente alla metà del Cinquecento. L’autore rettifica in manzò il verbo marò letto dallo scrittore Nino Cenni (= «mangiarono»).
24. Recensione di: Wilhelm Baum, Geschichte der Zimbern, 1983 - in TC n. 56-57, 1984, pp. 102-110.
25. Traduzione di una serie di testi settecomunigiani, pubblicati sotto il titolo Scritti di Umberto Martello in TC n. 58, 1984, pp. 21-46.
26. Precisazione sul termine recoarese “palansín” (“palissín”) - in TC n. 58, 1984, pag. 62.
27. Recensione di: Don Alberto Benedetti, Insediamenti umani sulla montagna veronese, 1983 - in TC n. 58, 1984, pp. 75-78.
28. Una visita all’Università dell’Alaska - in IP n. 1, 1985, pp. 5-8.
È dato qui il resoconto di un viaggio fatto da Rapelli a Fairbanks tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto del 1984; qui egli incontrò l’amico prof. John H. Koo, docente di linguistica, che gli mostrò i locali dell’università dell’Alaska piú la biblioteca, molto ricca di pubblicazioni concernenti le popolazioni artiche.
29. Recensione di: Anthony R. Rowley, Fersentaler Wörterbuch: Fersentaler Dialekt - Deutsch - Italienisch / Vocabolario del dialetto tedesco della Valle del Fèrsina nel Trentino: Dialetto - Tedesco - Italiano, 1982 - in TC n. 59, 1985, pp. 65-66.
30. Recensione del periodico di studi cimbrici di Landshut (Baviera) Cimbernland n. 1, 1983, in TC n. 59, 1985, pp. 66-67.
31. Segnalazione del periodico Cimbernland (di cui al § 30 qui sopra) n. 2, 1983, in TC n. 59, 1985, pag. 67.
32. Segnalazione di: Anselmo Sauro, Le origini della popolazione dei Tredici Comuni Veronesi, 2ª ediz. 1984 - in TC n. 59, 1985, pag. 68.
33. Lettera ad Ar. del 13 luglio 1985 per far notare l’esistenza della maschera di Bertoldo nel carnevale veronese (è uno dei personaggi del rione della Carega), contrariamente a quanto affermato da tale G. Fornaciari.
34. Cultura “minore”: il significato delle nostre località - in LVS n. 10, 20 settembre 1985, pag. 6.
Trattazione etimologica a carattere divulgativo di toponimi del Villafranchese.
35. Cognomi di Villafranca tre secoli fa - in LVS n. 11, 15 novembre 1985, pag. 10 (Prima Parte), e n. 1, 30 gennaio 1986, pag. 10 (Seconda Parte).
Trattazione etimologica a carattere divulgativo di cognomi villafranchesi del 1681 e 1682.
36. Lettera ad Ar. del 6 febbraio 1986 contenente l’etimo del toponimo Buttapietra da un soprannome «che butta pietre» (a confutazione di un’ipotesi di tale Gianni Serate «terreno che butta pietre»).
37. Ipotesi etimologica su Ciba vezzeggiativo di “Silvana” apparsa in “Il Nuovo Veronese”, settimanale di Verona, del 30 marzo 1986.
L’ipotesi fu richiesta per telefono dalla giornalista Emma Cerpelloni.
38. Segnalazione di: Silvio Pontani, Lingue straniere e realtà territoriale, 1985 - in TC n. 63, 1986, pag. 63.
39. L’angolo culturale: storia di parole - in LVS n. 10, 15 dicembre 1986, pag. 3.
Trattazione etimologica dello pseudo-nome veronese Matío Cópo (nell’espressione ai tempi de M. C. «in tempi lontanissimi»).
40. Il piccolo mondo dei “Cimbri” appena fuori di Verona - traduzione dell’articolo di Sv. Aa. Andersen Cimbrernes lille verden lige udenfor Verona apparso sul quotidiano “Politiken” di Copenaghen dell’8 settembre 1968, in TC n. 64, 1986, pp. 11-13.
41. Etimologia dell’antico veronese corgo, voce usata contestualmente a vadus (= ver. vò) di cui talvolta pare sinonimo; apparsa in Enrico Paganuzzi, Il “perlaro” e l’acqua dell’Adige nei madrigali trecenteschi per le nozze di Francesco Bevilacqua e Anna Zavarise, in AASV 1986-87, pp. 424-425, nota.
42. Storia di parole: ovo, galina e cul caldo - in LVS n. 1, 25 gennaio 1987, pag. 5.
43. Storia di parole: le sfoiadine - in LVS n. 2, 15 marzo 1987, pag. 3.
44. Storia di parole: i schèi - in LVS n. 2, 15 marzo 1987, pag. 3.
45. Il veronese parlato al tempo di Cangrande - in LVS n. 3, 10 aprile 1987, pag. 4.
46. Il dialetto: parente povero o con pieni diritti? - in “Scuola Europa Cultura”, periodico quadrimestrale di Verona, n. 1, 1987, pag. 11.
47. Storia di parole: sénti stà mi? ’sa énti dito? - in LVS n. 4, 10 maggio 1987, pag. 6.
48. Traduzione dal tedesco dell’articolo di Maria Hornung sul Museo austriaco delle isole linguistiche, in TC n. 65, 1987, pp. 47-52.
49. Storia di parole - in LVS n. 7, 1º luglio 1987, pag. 6.
Breve trattazione di tre modi di dire veronesi: ’verghe i moreti; no ’vérghene gnanca da passar el ponte; el vien subito e ’l va via a onsa a onsa.
50. Collaborazione alla mostra Le pietre del fuoco, tenuta dal 18 luglio al 31 agosto 1987 al Cerro.
Attuata redigendo i testi delle etimologie delle espressioni veronesi folénda, bati-assalín e sita («limonite») oltre al pannello esplicativo I Cimbri al Cerro.
51. Storia di parole: maiàr «mangiare» - in LVS n. 8, 30 settembre 1987, pag. 3.
Breve trattazione etimologica di questa parola e delle altre due similari usate nel Veronese magnàr e (di documenti antichi) manz´àr.
52. Curiosità linguistiche: la pearà e i nomi mal tradotti delle vie di Verona - in LVS n. 9, 25 ottobre 1987, pag. 2.
53. Toponomastica a Villafranca: “la Siéna” - in LVS n. 1, 12 febbraio 1988, pag. 3.
54. Lingue che vanno scomparendo - Cimbro: ancora pochi anni e scenderà il silenzio - in “Scuola Europa Cultura”, periodico quadrimestrale di Verona, n. 5, 1988, pag. 10.
55. Lettera ad Ar. del 24 ottobre 1988 contenente l’etimo dell’espressione veronese gnochi smalzài (a confutazione di un’ipotesi avanzata in merito dal gastronomo Giorgio Gioco secondo cui all’origine era il tedesco Mahlzeit «buon appetito»).
56. A cosa serve il dialetto? - in LVS n. 9, 15 dicembre 1988, pag. 3.
57. Lettera ad Ar. del 24 dicembre 1988 contenente l’etimo della voce veronese meàl «soglia», perfetto corrispondente dell’ital. limitare (a confutazione di un’ipotesi errata in proposito di tale Luigi Franchi).
58. L’angolo culturale: parole nate a Verona (italiane e non) - in LVS n. 1, 15 febbraio 1989, pag. 3.
Breve trattazione delle voci — nate a Verona — filarmonico, sifilide, rivoltella, criminaloide, giallo «romanzo poliziesco», Veronal, pearà (e altre della gastronomia locale).
59. L’angolo culturale: modi di dire (“le scale de seda”; “parer Sparapètene”) - in LVS n. 2, 30 marzo 1989, pag. 3.
60. L’angolo culturale: modi di dire (“tirar simento”; “a la sanfassona”; “bala da fogo”; “a la va’ là che vegno”; “no ’vérghelo gnanca par i sete sentimenti”) - in LVS n. 3, 10 maggio 1989, pag. 3.
61. L’ultimo testo di Eligio Faggioni – in CT 2, 1989, pp. 12-20.
È pubblicato qui l’ultimo testo in cimbro (una sorta di autobiografia) lasciatoci dal poeta-boscaiolo di Giazza. Esso è contenuto in un nastro registrato, di cui Rapelli dà la trascrizione e la traduzione letterale; è riportata, inoltre, la traduzione libera effettuata dallo stesso Faggioni, che però non trascrisse il testo cimbro.
62. L’angolo culturale: modi di dire (“garanfati?”; “te la vansarè!”) - in LVS n. 5, 10 luglio 1989, pag. 3.
63. L’angolo culturale: modi di dire (“facia da peri còti”; “fermarse a ogni pissada de can”; “e la puarina che sta in Bra!”) - in LVS n. 6, 30 settembre 1989, pag. 3.
64. L’angolo culturale: modi di dire (“e ’l resto, bàila!”; “te me pari ’n’ava mata!”) - in LVS n. 7, 10 novembre 1989, pag. 3.
65. L’angolo culturale: modi di dire (“’ndar via de ficheton”) - in LVS n. 9, 25 dicembre 1989, pag. 3.
66. La parlata cimbra di Giazza - in “L’Almanacco di Verona 1990” n. 1, Verona gennaio-giugno 1990, pp. 212-213.
Sono riportati due brevi testi ripresi dal Cappelletti 1925 e dal Mercante 1936.
67. L’angolo culturale: modi di dire (“tampelar”; “giangianese”) - in LVS n. 1, 30 gennaio 1990, pag. 3.
68. Lettera ad Ar. dell’8 aprile 1990 contenente un’ipotesi sull’origine etnica di San Zeno, e sul perché egli fosse detto el Vescovo moro. Vi si sostiene la sua appartenenza a uno dei popoli camitici (Numidi, Mauri, Libi) dell’Africa del Nord, oppure ai Cartaginesi; la leggenda del moro nascerebbe da una tardiva identificazione dell’epiteto “Africano” con gli schiavi neri visti dai Crociati in Oriente (a confutazione di un’affermazione di tale Francesco Marchionni che S. Zeno era un negro).
69. Lettera ad Ar. del 31 ottobre 1990 contenente l’etimologia del toponimo Caovilla di Parona: a confutazione di un’ipotesi espressa una decina di giorni prima, vi si sostiene l’interpretazione «estremità del paese».
70. Dal Lago di Garda: fotografie di Silvio Tommasoli, 1920-1935 - volume di 112 pp. pubblicato dalle Edizioni Archivio Tommasoli, Verona 1991, con testi a cura di G. Rapelli.
È raccolta qui un’antologia di testi di vari autori relativi al lago di Garda.
71. Anima della cultura cimbra - in G. Faè, El ciaro grando, a cura di Piero Piazzola, Della Scala Edizioni, Verona 1991, pp. 9-11.
Una descrizione dell’attività in favore della cultura cimbra svolta da Gianni Faè (1921-83).
72. Lettera ad Ar. del 1º luglio 1991 con l’etimologia del cognome Mazzi; a confutazione di una fantasiosa ipotesi espressa da un articolista un mese prima, che voleva si trattasse di cognome cimbro.
73. Traduzione in tedesco del discorso di saluto del presidente dei Trombini di S. Bortolo (sig. Gugole), pubblicata nella Salzburger Trombini-Chronik, Salisburgo, giugno 1991.
74. Le parlate veronesi - in QP n. 2, agosto 1991, pp. 30-31.
75. Precisazione sull’etimologia del nome di località Goito - in QP n. 2, agosto 1991, pag. 31.
76. Curata la ripubblicazione del saggio di Carlo Cipolla Toponomastica dell’ultimo residuo della colonia alto-tedesca nel Veronese (Torino 1902) - in CT n. 5-6, 1991, pp. 121-165.
È data qui una nuova traduzione di tutti i nomi di località, relativi all’area di Giazza, riportati nel saggio — traduzione a volte differente da quella del Cipolla — con brevi commenti di carattere linguistico.
77. Compilazione dei testi di commento alle fotografie della mostra “Fotostoria di Borgo Venezia”, tenutasi alla Scuola Media Carducci (Via Betteloni, Verona), 7-21 dicembre 1991.
Le foto erano circa 70. I testi erano suddivisi in didascalie vere e proprie e pannelli storici relativi alle ripartizioni della mostra, B. Venezia, Barana-Biondella-Ceolara, B. Trieste, Progno Pantena, B. S. Croce, Le Corti di S. Felice. Parte di questi testi è stata ripresa, con qualche modifica, in una mostra fotografica sulla nascita della parrocchia di S. Giuseppe Fuori le Mura (in occasione dell’80º anniversario) tenutasi nel periodo 23 sett. - 22 ott. 1995 nella chiesa stessa. Nel periodico parrocchiale “Fuori le mura” dell’autunno 1995 viene ripubblicato, a pag. 3, l’articolo La nascita di Borgo Venezia, ripreso dai testi della mostra.
78. Le forme del pane nelle valli dell’Adige - volume di 112 pp. pubblicato dalle Edizioni Archivio Tommasoli, Verona 1992, con testi a cura di G. Rapelli.
È raccolta qui un’antologia di testi di vari autori relativi al pane delle vallate atesine, in tutti i suoi aspetti.
79. I Cimbri fra di noi - in QP n. 1, aprile 1992, pp. 21-24.
Articolo divulgativo sui Cimbri in genere. Ripubblicato in CT n. 8, 1992, pp. 157-163.
80. Etimologia del toponimo Val Fraselle - in Giuseppe Rama, Val Fraselle: natura, toponomastica, folklore, Cierre Edizioni, Verona 1992, pag. 13.
81. Lettera ad Ar. del 6 ottobre 1992 facente seguito a un articolo sul significato del nome Porta Vescovo, con una proposta etimologica nuova.
82. Lessinia, colonia del Tirolo: con la benedizione del vescovo partí la conquista dei cimbri - in Ar. del 18 ottobre 1992, pag. 21.
Articolo che tratteggia la storia a grandi linee della popolazione cimbra veronese.
83. Collaborazione linguistica al volume di John H. Koo - Robert N. St. Clair (with the assistance of Giovanni Rapelli), Languages of the World [= «Le lingue del mondo»], pp. 342, Hanshin Publishing Co., Seul 1992.
La collaborazione consistette nel rivedere accuratamente le bozze al fine di rilevare eventuali errori od omissioni nelle lingue citate, nei brani linguistici addotti a esempio, nelle cartine, nelle tabelle, ecc. In piú, Rapelli approntò per gli autori una ventina di cartine linguistiche (delle grandi famiglie quali l’indoeuropeo, il sino-tibetano, ecc.), un paio delle quali vennero accolte nel volume, e redasse diversi, piccoli testi aggiuntivi o esplicativi.
84. Lettera ad Ar. del 1º aprile 1993 (pubblicata col titolo Don Mercante: nuova testimonianza sulla morte) in cui si chiede che parli finalmente chi conosce la verità sugli ultimi momenti di vita di don Domenico Mercante, parroco di Giazza fucilato dai Tedeschi in fuga il 27 aprile 1945.
85. Gianni Faè e la cultura della montagna - in CT n. 9, 1993, pp. 19-24.
Ricordi personali di Rapelli sui suoi rapporti con G. Faè, iniziati nel 1966, e brevi cenni biografici sullo stesso Faè.
86. Lettera ad Ar. del 12 agosto 1993 (pubblicata col titolo Gnocchi: com’erano a Verona prima delle patate) in cui si commenta un articolo di Michele Gragnato sugli antichi gnocchi veronesi. Sono riportate qui informazioni relative al momento preciso dell’introduzione della patata nel Veronese.
87. Villafranca Veronese: da “Campagna” a “Burgo Libero” - in QP n. 2, agosto 1994, pp. 66-68.
88. Recensione di: Il Vangelo secondo Giovanni in lingua cimbra, a cura di autori vari, Vicenza 1993 - in CT n. 12, 1994, pp. 137-138.
89. Intervento alla Festa dei Cimbri del 3 luglio 1994 a Badia Calavena, pubblicato col titolo Introduzione in CT n. 12, 1994, pp. 139-141.
90. Note storiche su Borgo Venezia - in SVE n. 1, 1994, pag. 7 (Prima Parte), e n. 2, 1994, pp. 8-9 (Seconda Parte).
91. Lettera ad Ar. del 23 maggio 1995 (pubblicata col titolo Saval: quello storico è di là dall’Adige) in cui si contesta l’affermazione di B. Fracaroli che il vero Saval è l’attuale quartiere e non la contradina a sinistra d’Adige.
92. Il Buso del Gato - in SVE n. 3, 1995, pag. 12.
Contiene l’etimologia di questo curioso toponimo veronese.
93. Lettera ad Ar. del 21 luglio 1995 (pubblicata a pag. 13 col titolo San Giacomo fu fatto per i lebbrosi) in cui si confuta l’affermazione di un giornalista che l’ospedale di S. Giacomo era destinato nel Medioevo agli ammalati della pelle.
94. Recensione di: Alberto Castaldini, Il calice di S. Giovanni: il culto di San Giovanni Evangelista nella religiosità dei Cimbri, Roana (Vicenza) 1995 - nel settimanale “Verona fedele” del 10 luglio 1995, pag. 15. Ripubblicata in CT n. 14, 1995, pp. 219-220.
95. La Biondella: significato del nome - in SVE n. 4, 1995, pag. 13.
96. Testimonianze dai Cipolla - in CT n. 14, 1995, pp. 119-130.
Sono riportati qui 7 brani ripresi dai fratelli Cipolla relativi alla religiosità e alle superstizioni della gente di Giazza (6 sono tradotti a cura di Rapelli dal cimbro).
97. Lettera ad Ar. del 17 ottobre 1995 (pubblicata a pag. 12 col titolo Scrutamai: a Povegliano una parola altolombarda) sull’etimologia delle voci della Bassa scrutamai, scotumai e scutumai «soprannome».
98. Facezie linguistiche: i nomi di persona “nippo-veneti” - in SVE n. 5, 1995, pag. 11.
Articoletto su un curioso fenomeno pseudo-linguistico: gli scherzosi cognomi apparentemente giapponesi, ma in realtà composti con parole venete, che si sentono talvolta in bocca al popolo. Ne è apparso un sunto in RIOn n. 1, 1999, pp. 316-317.
99. Verona: un secolo d’immagini nell’archivio Tommasoli - volume di 160 pp. pubblicato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona, Verona 1996, con testi a cura di G. Rapelli.
È raccolta qui un’antologia di testi di vari autori relativi alla città Verona; alcuni sono stati tradotti dallo stesso Rapelli.
100. Parole italiane nate a Verona - in SVE n. 6, 1996, pag. 11.
Rifacimento dell’articoletto riportato qui sopra col § 58.
101. Lettera ad Ar. dell’8 agosto 1996 (pubblicata a pag. 14 col titolo Etimologia: Pantalone non deriva da pianta leon) sull’etimologia del nome veneziano Pantalon e dei pantaloni «calzoni».
102. La Croce Rossa fu inventata qui e La Croce Rossa simbolo di pace, due puntate di uno stesso articolo sulla nascita della Croce Rossa apparse nel settimanale “Verona fedele” rispettivamente n. 37, 22 settembre 1996, pag. 35, e n. 38, 29 settembre 1996, pag. 36.
103. Modi di dire popolari: “te la vansarè!”, “gh’è-to i moreti?”, “testa da porton!” - in SVE n. 7, 1996, pag. 14.
104. Lettera ad Ar. del 24 ottobre 1996 (pubblicata a pag. 15 col titolo San Zeno: le mie ipotesi sugli Orti di Spagna) sull’etimologia del terreno detto Spagna da cui ha origine il toponimo Orti di Spagna.
105. Cimbri e Longobardi - in “Cimbri notizie / Tzimbar Naugaz”, bollettino semestrale del Curatorium Cimbricum Veronense, luglio-dicembre 1996, pag. 8.
Articoletto dedicato a confutare la tesi dell’origine longobarda dei Cimbri.
106. Modi di dire popolari: “garanfati!”, “alà, oco marín!”, “el te para intorno come un móscolo”, “te me pari un guíndolo”, “e ’l resto, bàila!”, “al tempo de Matío Copo” - in SVE n. 8, 1996, pag. 12.
107. Lettera ad Ar. del 7 gennaio 1997 (pubblicata a pag. 15 col titolo Croazia: informazioni su Lovran e Opatija) per puntualizzare che le città “croate” di Lovran e Opatija altro non sono che le istriane Laurana e Abbazia, già abitate da numerosi Italiani.
108. Cenni storici su S. Michele Extra - in Mar. del febbraio 1997, pag. 8.
109. Recensione di: Michael Fortescue - Steven Jacobson - Lawrence Kaplan, Comparative Eskimo Dictionary, with Aleut Cognates - in IP n. 1, marzo 1997, pag. 92.
110. Sei Ville: cenni storici - nell’opuscolo Sei Ville: 25º anniversario 1973-1997, Verona 1997, pag. 13.
La Sei Ville è una popolare corsa podistica; i cenni storici si riferiscono alle ville vicino alle quali si snoda la marcia.
111. Curiosando qua e là nella storia - nell’opuscolo Sei Ville: 25º anniversario 1973-1997, Verona 1997, pag. 17.
Brevi cenni storici sulla zona tra il Ponte Florio e Montorio.
112. Le origini di Verona - in Mar. del maggio 1997, pag. 6.
113. I Reti e l’area baldense - nel periodico di Caprino “Il Baldo: quaderno culturale 1997”, n. 8, 1997, pp. 63-67.
Articoletto che accenna alla presenza dei Reti nell’area del Monte Baldo.
114. Recensione di: Ulderico Bernardi, La Babele possibile: per costruire insieme una società multietnica, Milano 1996 - in CT n. 17, 1997, pp. 181-182.
115. Notiziole su Grezzana - in Mar. del giugno 1997, pag. 4.
116. Curiosando su Camposilvano - in Mar. del luglio-agosto 1997, pag. 8.
117. S. Antonio e la nostra “24 ore”: la Pace di Paquara - in Mar. del settembre 1997, pag. 4.
Articoletto per l’occasione di una marcia podistica detta “24 ore”. Tratta della duecentesca Pace di Paquara (stipulata vicino a S. Giovanni Lupatoto), propiziata anche da s. Antonio di Padova.
118. Boscochiesanuova: frammenti di storia - in Mar. dell’ottobre 1997, pag. 4.
119. Come è nato Borgo Venezia - in Mar. del novembre 1997, pag. 4.
120. Qualcosa su Peschiera - in Mar. del dicembre 1997, pag. 10.
121. Breve saluto da parte dei visitatori del Curatorium ai rappresentanti dei Walser, composto in cimbro e pronunciato da Rapelli a Macugnaga il 24 maggio 1997; pubblicato in CT n. 18, 1997, pag. 142.
122. Il libretto cimbro di Giovanni Battista Pighi - in CT n. 18, 1997, pp. 115-117.
Recensione-commento di un curioso libriccino di 72 pagine (piccolissimo, cm 5,7 x 7,2), intitolato Tautsch: preghiere proverbi filastrocche cantilene e canti delle campane, che il Pighi diede alle stampe nel 1964. Vi sono riportati proverbi e testi tratti da mons. Cappelletti, piú una dedica in cimbro (priva di traduzione) composta probabilmente dallo stesso Pighi.
123. Un’intervista a Maria Dal Bosco - in CT n. 18, 1997, pag. 118.
È riportata qui parte di un’intervista fatta a una signora di Giazza nel 1983 e pubblicata ne “L’Arena” del 10 settembre di quell’anno: si tratta di un brevissimo discorso in cimbro, che il giornalista tradusse erroneamente. Rapelli ne dà una versione piú esatta.
124. Piccole aggiunte al vocabolario dei XIII Comuni - in CT n. 18, 1997, pp. 119-121.
Si tratta di cinque voci cimbre udite da Rapelli nei suoi incontri con la gente di Giazza e non riportate in nessun vocabolario.
125. Parliamo di Avesa - in Mar. del gennaio 1998, pag. 8.
126. Modi di dire: “nóvo de bala”, “sigar come ’n’anguana”, “butar in vaca”, “dormir da l’ultima”, “dormir come ’n pantasso” - in SVE n. 9, 1997, pag. 12.
127. A proposito di una recensione - in “Dolomiti” (rivista bimestrale di Belluno) n. 6, 1997, pag. 64.
Breve commento a una recensione negativa del volumetto di Rapelli I Cimbri veronesi apparsa a firma Giorgio Marcuzzi in “Dolomiti” n. 4, 1997, alle pp. 35-36.
128. Lettera ad Ar. del 25 gennaio 1998 (pubblicata parzialmente a pag. 15) con precisazioni sulla poesia di Berto Barbarani San Zen che ride.
129. Recensione di: Massimo Pittau, La lingua etrusca: grammatica e lessico, Nuoro 1997 - apparsa in Ar. del 26 gennaio 1998, pag. 7, senza firma.
130. La dolce Valpolicella - in Mar. del febbraio 1998, pag. 4.
131. Venezia e Verona - in Mar. del marzo 1998, pag. 4, e dell’aprile 1998, pag. 4.
132. 1953: nasce Borgo Trieste - in 26ª Sei Ville: sport, natura & cultura, opuscolo per la XXVI edizione della marcia Sei Ville (19 aprile 1998), Verona 1998, pag. 15.
133. Traduzione in tedesco — assieme ad Anna Gasser — del volumetto di Alberto Castaldini Il calice di S. Giovanni: il culto di San Giovanni Evangelista nella religiosità dei Cimbri (Roana 1995), apparso col titolo Der Kelch des heiligen Johannes: die Verehrung des heiligen Evangelisten Johannes in den zimbrisch-deutschen Sprachinseln, pp. 98, Vienna 1998.
134. Il Tamburino Sardo - in Mar. del maggio 1998, pag. 8.
A Custoza v’è la Casa del Tamburino Sardo; traendo lo spunto da questo toponimo, del tutto arbitrario, Rapelli accenna brevemente al racconto del “tamburino sardo” del De Amicis.
135. Da arma di offesa ad arma di parata, relazione al I Convegno nazionale su “Il trombino”, Badia Calavena 2 giugno 1996 - in Il trombino: I e II convegno nazionale, a cura di Nereo Stoppele, Gruppo Folkloristico “I Pistonieri dell’Abbazia” di Badia Cal., Badia Calavena (Verona) 1998, pp. 31-35.
Articolo nel quale si propone l’evoluzione del “trombino” da arma offensiva ad arma di parata nel tempo successivo alla guerra di Cambrai, quando v’è un lungo periodo di pace.
136. I trombini e la difesa dei confini settentrionali del Veronese, relazione al II Convegno nazionale su “Il trombino”, Badia Calavena 8 giugno 1997 - in Il trombino: I e II convegno nazionale, a cura di Nereo Stoppele, Gruppo Folkloristico “I Pistonieri dell’Abbazia” di Badia Cal., Badia Calavena (Verona) 1998, pp. 87-91.
Articolo in cui v’è un ripensamento di Rapelli sull’origine del trombino: contrariamente a quanto sostenuto nel precedente scritto (§ 135), l’autore pensa ora che l’arma sia subito nata come arma folkloristica, senza che sia mai stata usata per scopi bellici. Egli, infatti, non trova mai riferimenti a un’arma del genere nelle cronache antiche.
137. Cenni storici - in Internet, www.rcvr.univr.it/scuole/King/, file://A:\storia.htm, 14 maggio 1998.
È una pagina di cenni storici su S. Michele Extra.
138. Lettera al periodico “Panorama” di Fiume, n. 12 del 30 giugno 1998, pubblicata a pag. 20 col titolo I cognomi di Veglia, in cui Rapelli propone la derivazione dei veglioti Celebrini e Kapovila rispettivamente da cerebrum e cao (de) vila.
139. Parliamo di S. Martino Buon Albergo - in Mar. del settembre 1998, pag. 4.
140. Grezzano e i Canossa - in Mar. dell’ottobre-novembre 1998, pag. 4.
141. Saluto ai Walser di Gressoney - nel periodico semestrale “Cimbri notizie / Tzimbar Naugaz” n. 14, 1998, pag. 12.
Breve discorso nel cimbro di Giazza composto da Rapelli e pronunciato dallo stesso nel corso di una visita culturale del Curatorium ai Walser di Gressoney.
142. Saluto alla Festa dei Cimbri - apparso senza firma nel periodico semestrale “Cimbri notizie / Tzimbar Naugaz” n. 14, 1998, pag. 12.
Una preghiera composta nel cimbro di Giazza da Rapelli e pronunciata (da altri) nella chiesa di S. Bortolo il 5 luglio 1998.
143. Gratzie! - in CT n. 20, 1998, pag. 73.
Breve discorso in cimbro tredicicomunigiano composto da Rapelli e pronunciato dallo stesso in occasione della sua nomina a Gran Massaro dei Cimbri, avvenuta a S. Bortolo il 5 luglio 1998.
144. Nuove considerazioni marginali sull’etimo della parola “Cimbro” - in CT n. 20, 1998, pp. 99-102.
È avanzata qui una nuova ipotesi marginale sull’etimo di Cimbro: lo *zimberer «carpentiere, falegname, boscaiolo» che ne è alla base non sarebbe stato usato principalmente dagli antichi Cimbri, ma sarebbe stato assegnato loro dai Tedeschi (pur riprendendo un termine comune tra i primi Cimbri) che frequentavano in grande numero Verona al tempo degli Scaligeri.
145. Ancora sulla voce cimbra per “cipolla” - in CT n. 20, 1998, pp. 102-103.
Viene fatto rimarcare che il lessema antico-veronese *zevólla «cipolla», ricostruito nell’articoletto riportato col § 46 in “Articoli”, è corroborato dall’attestazione in un documento di Roverchiara del 1213 cevollas bavosias.
146. Personaggi cimbri: Domenico Catazzo - in CT n. 20, 1998, pp. 105-106.
147. Lettera ad Ar. del 28 novembre 1998, pubblicata a pag. 18 col titolo Toponimi: Bórsari e non Borsàri, lo dice il popolo, per deplorare l’accentazione sbagliata che usano molti per la Porta Bórsari, con varie osservazioni etimologiche.
148. Santa Lússia - in Mar. del dicembre 1998, pag. 3.
Breve schizzo della tradizionale festa veronese e della sua origine, con la spiegazione del detto popolare a S. Lússia ’na ponta de ucia, a Nadal un passo de gal («a S. Lucia una punta d’ago, a Natale un passo di gallo»).
149. Precisazione sul sistema di grafia adottato nel volume I cognomi di Verona e del Veronese... (vedi “Volumi”, § 8) e su vari altri particolari relativi all’etimologia dei cognomi - in RIOn n. 1, 1998, pp. 315-316.
150. Lettera ad Ar. del 27 dicembre 1998, pubblicata a pag. 16 col titolo Etimologie: l’origine del nome Borsari, con cui Rapelli replica a una precisazione di Gian Maria Varanini sulla stessa Ar. (del 5 dicembre) a proposito dell’etimo della Porta Bórsari. Sono esposte qui le ragioni dei dubbi sull’etimo abitualmente dato dei bursarii (a continuazione del discorso di cui al § 147 qui sopra).
151. Bardolino: frammenti di storia - in Mar. del gennaio 1999, pag. 3.
152. L’“euro” e la storia della lira - in Mar. del febbraio 1999, pag. 3.
153. Cadicozzi, il Carota e un monastero - in Mar. del marzo 1999, pag. 5.
Spiegazione etimologica dei toponimi veronesi Cadicozzi e Carota.
154. Da Clivus fino al... Ceo - nel periodico “Clivus” del Chievo presso Verona n. 3, febbraio 1999, pag. 1.
Spiegazione etimologica del toponimo veronese il Chievo.
155. Lettera ad Ar. del 21 maggio 1999, pubblicata a pag. 18 col titolo Carega: quel nome è un termine veronese, in cui è contestato un precedente articolo attribuente un etimo cimbro al Monte Carega; con essa viene proposta la derivazione dal ver. caréga «sedia», facendo notare che invece è prettamente cimbro il nome della Cima Posta, da púrkstal «vetta appuntita».
156. Il tauc´ - in Ljetzan/Giazza, numero speciale 21 di CT, gennaio-giugno 1999, pp. 95-100.
Articoletto divulgativo sul cimbro tredicicomunigiano.
157. Gianni Faè (1921-1983); Hugo F. Resch (1925-1995); Benigno Petterlini; Eligio Faggioni - in Ljetzan/Giazza, numero speciale 21 di CT, gennaio-giugno 1999, rispettivamente pp. 105; 105-106; 178-179; 185-186.
Si tratta di quattro brevi biografie.
158. Da “Italien-Spiegel” - in CT n. 22, 1999, pag. 69.
Breve commento di un articolo sui Cimbri veronesi scritto nel 1943 su una rivista delle forze armate tedesche in Italia (l’articolo viene riportato nelle pagine seguenti, tradotto a cura di Giuseppe Corradi).
159. In memoriam: Giulia Mastrelli Anzilotti - in CT n. 22, 1999, pag. 123.
Commemorazione della scomparsa della linguista G. Mastrelli Anzilotti (avvenuta il 29 marzo 1999).
160. Recensione di: Alberto Castaldini, Der Kelch des heiligen Johannes: die Verehrung des heiligen Evangelisten Johannes in den zimbrisch-deutschen Sprachinseln, Vienna 1998 - in CT n. 22, 1999, pag. 125.
Si tratta del volume di cui al § 133 qui sopra.
161. Parliamo un po’ del Carnevale! – in Mar. del febbraio 2000, pag. 5.
Sono delineate le uniche due figure storiche del carnevale veronese: il Bupà del Gnoco e il Duca de la Pignata.
162. Parliamo un po’ del Carnevale! (II) – in Mar. del marzo 2000, pag. 7.
Tratta di due maschere del carnevale veronese derivate da persone effettivamente esistite nella storia della città: Simeone dall’Isolo e il Principe Reboano. La prima ricorda tale Simeone Dalla Riva, vissuto nella prima metà del Trecento; la seconda ricorda tale Reboano o Rabàno Dalle Carceri, vissuto tra XII e XIII secolo.
163. Lettera ad Ar. del 22 marzo 2000, pubblicata a pag. 17 col titolo Idee confuse sulla toponomastica, in cui si ribatte a un lettore che contestava l’etimologia tumba «sporgenza del terreno» per la località Tomba di Verona, derivandola invece da tomba «sepolcro». Rapelli dimostra che quest’ultimo termine non è mai esistito nell’antico Veneto, dove a “sepolcro” corrispondeva arca.
164. Perché la Pasqua… oscilla? – in Mar. dell’aprile 2000, pag. 7.
Breve trattazione del perché la Pasqua sia una festa mobile, e non fissa.
165. Maggio… e i suoi compagni – in Mar. del maggio 2000, pag. 11.
Breve trattazione etimologica dei nomi dei mesi.
166. Recensione di: Marino Bonifacio, Cognomi del comune di Pirano e dell’Istria (II), Pirano 1998 – in RIOn n. 1, 2000, pp. 181-182.
Sono messe qui in risalto, tra l’altro, alcune intuizioni etimologiche dell’autore: Del Senno da lat. senex, Zudich versione croato-slovena dello spalatino Giudici, Gussi (con le varianti Gusi, Gossi e Gussich) da non confondere coi cognomi veneti tipo Guzzo/Guzzi, Franza da “Francia” e non certo da “frangia”. Rapelli dà per l’occasione l’etimo del dalmatico Còsulich: dal veglioto *cóssul «console», con un suffisso ovviamente slavo.
167. Lettera ad Ar. del 7 agosto 2000, pubblicata a pag. 15 col titolo Via Nuova è documentata dal 1370. Reagendo a un articolo apparso il 30 luglio, secondo cui la celebre Via Nuova di Verona sarebbe stata creata dai Visconti (signori dal 1387), Rapelli scrive che il prof. Paganuzzi ha dimostrato già da tempo che in realtà il toponimo Via Nova è documentato in un rogito del 1370, risalendo però con ogni probabilità a qualche anno prima: in ogni caso, sotto il dominio di Cansignorio Della Scala, e non dei Visconti.
168. Lettera ad Ar. del 3 sett. 2000, pubblicata a pag. 17 col titolo Due storie legano Corfú e Verona. In un articolo del 27 agosto, il prof. Francesco Vecchiato citava come legami tra le due città le figure di Michele Sammicheli e di Giovanni Mattia Schulenburg; Rapelli aggiunge a queste Filippo Psalidi (1743-1812), di cui ancora vivono a Verona i discendenti, e Giovanni Salimbeni (1719-1808), entrambi Veneti nativi di Corfú (il primo, di stirpe greca).
169. Lettera ad Ar. del 20 sett. 2000, pubblicata a pag. 25 col titolo Etimologie: ne propongo una terza per Isola Rizza. In un articolo del 15 sett. si proponevano due possibili etimologie per il paese di Isola Rizza; Rapelli aggiunge a queste quella che gli sembra piú plausibile, *isola porca riza «isola “riccia”, piena di ricci (Erinaceus europaeus italicus; nel ver. locale porco rizo)».
170. Eschimesi: gli uomini del grande freddo – nel periodico della Compagnia di Gesú “Popoli” n. 10, ott. 2000, pp. 27-29.
Articolo divulgativo sugli Inuit, o Eschimesi. Purtroppo, la versione originale è stata malamente accorciata e alterata dalla redazione della rivista.
171. La riva veronese del Garda nei suoi castelli – in Mar. del nov. 2000, pag. 7.
Breve rassegna storica.
172. Giazza: etimologia del nome – nel periodico semestrale “Cimbri notizie ⁄ Tzimbar Naugaz” n. 17-18, 2000, pag. 8.
173. Recensione di: Raffaele De Rosa, Il “cimbro del Cansiglio”: convergenze e divergenze con il lessico delle altre parlate cimbre (“Saggi dialettologici in area italo-romanza”, V raccolta), Padova 2000, pp. 69-115 - in CT n. 24, 2000, pag. 161.
174. Articoletto senza titolo in RIOn n. 2, 2000, pp. 657-658.
È discusso qui l’etimo della Porta Bórsari di Verona.
175. Mille e non piú Mille? – in Mar. del genn. 2001, pag. 2.
Articoletto sulla credenza che sarebbe giunta la fine del mondo a mille anni di distanza dalla nascita (o dalla morte) di Cristo.
176. Lettera ad Ar. del 13 gennaio 2001, pubblicata a pag. 25 col titolo Dialetto: inserire la conoscenza tra i giovani. Sono contestate qui certe affermazioni del preside del Liceo Maffei, prof. Butturini, secondo cui il dialetto non serve praticamente a nulla, e la scuola avrebbe solo il compito di insegnare italiano, lingue straniere e Internet.
La lettera, troppo lunga, fu pubblicata mutila della parte finale, dove Rapelli dimostra quanto sia stato importante l’apporto alla lingua fornito dai dialetti, ivi comprese due delle espressioni italiane piú usate, ciao e grazie. In calce vi si aggiungeva che anche Verona ha dato qualcosa alla lingua nazionale: arcovolo nel senso di «arcata di un anfiteatro».
177. Il valore dell’identità veneta – in “Atti del convegno ‘Mondo veneto’, 15 ottobre 2000”, pp. 11-13.
Intervento a un piccolo convegno nell’ambito della consegna del Premio letterario “Mario Donadoni”. Si sostiene qui la necessità del dialetto nei confronti della lingua nazionale: questa statica e congelata per forza di cose, quello eternamente rigenerantesi perché libero da vincoli di ufficialità. Sono dati molti esempi di voci dialettali penetrate nell’italiano.
178. Lettera ad Ar. del 23 febbraio 2001, pubblicata a pag. 25 col titolo San Serafino e il pagano Serapide. Viene contestata qui l’opinione di tale Luigi Pellini (erroneamente riportato come Bellini), di Oppeano, che il culto a Ca’ del Ferro di Oppeano di S. Serafino continui quello del dio romano Serapide; che nel nome di Parigi si perpetui quello di Iside; e che il toponimo Oppeano derivi dalla dea romana Opi.
179. Montorio – in Mar. del marzo 2001 (I Parte), pag. 7, e dell’apr. 2001 (II Parte), pag. 7.
Breve trattazione storica divulgativa della frazione di Verona, già comune autonomo.
180. Lettera ad Ar. del 9 marzo 2001, pubblicata a pag. 25 col titolo Oppeano: da dove deriva il toponimo. In risposta a Dino Coltro, che in Ar. del 5 marzo 2001 si rivolge direttamente a Rapelli (in un articolo sulla questione di S. Serafino, si veda qui sopra il § 178), l’autore espone con una certa completezza la sua opinione sull’etimo di Oppeano: da castrum oppidanum o da fundus oppidanus, dove non è chiaro il senso dell’aggettivo («della città»?, «provinciale»?).
181. Lettera ad Ar. dell’8 aprile 2001, pubblicata a pag. 21 col titolo Ricordi: il Buso del Gato nei libri. È contestata qui la datazione di una stampa raffigurante la stazione di Porta Vescovo a Verona, pubblicata in Ar. 26 marzo 2001: l’autore dell’articolo dove questa compariva, tale P. M. (= Piero Marcolini), la fissava al 1904, mentre Rapelli dimostra che doveva risalire al periodo 1850-1866, piú probabilmente agli anni 1850-1852. Ne consegue che il Buso del Gato non venne costruito attorno al 1904, ma cinquant’anni prima. Sono contestati qui, poi, l’etimologia del nome e un termine dialettale citato dall’autore.
182. Lettera ad Ar. del 13 nov. 2001, pubblicata a pag. 23 col titolo Tim Parks: si ricordi di Genoa e Sampdoria. Lo scrittore inglese residente a Verona aveva dileggiato la squadra calcistica del Chievo Verona e la stessa frazione del Chievo; Rapelli osserva che allora anche la Sampdoria non dovrebbe avere titoli per competere col ben piú blasonato Genoa, essendo sorta anch’essa nella frazione genovese di S. Pier d’Arena.
183. Collaborazione linguistica all’opuscolo di David Conati La Ricompensa: storia de strie, amor e saladi, commedia in 2 atti (per circa 11.000 parole) pubblicata a cura dell’autore, Soave 2002.
La commedia — scritta da un giovane commediografo di Soave — è in dialetto veronese; la collaborazione è consistita nel curare che la forma di dialetto da usarsi fosse quella della Lessinia orientale (alta Val d’Alpone, ecc.) e non altra.
184. Lettera ad Ar. del 30 genn. 2002, pubblicata a pag. 21 col titolo Pizzerie: la prima era vicino al Corallo. Contestando un articolo nel quale si affermava che la prima pizzeria al taglio fu in Piazza Erbe nel 1967, Rapelli scrive che la prima ebbe sede in realtà in Via Quattro Spade; quella di Piazza Erbe fu la seconda, seguita nell’autunno del 1967 da quella di Vincenzo Righetti in Via S. Nazaro.
185. Lettera ad Ar. del 1° marzo 2002, pubblicata a pag. 23 col titolo Toponimi: il nome degli Orti di Spagna. Contro un’affermazione di Gabriella Lombardo che gli Orti di Spagna derivano dall’erba spagna «erba medica», Rapelli ne sostiene l’origine dal nome *Spagna di un antico proprietario del sito (a sua volta derivato da un pellegrinaggio a Santiago di Compostella o dalle leggende cavalleresche).
186. Lettera ad Ar. del 21 marzo 2002, pubblicata a pag. 23 col titolo I resti scoperti nel Vicolo. In un articolo apparso l’11 marzo si informava i lettori della scoperta di molte ossa umane nel Vicolo Cieco S. Francesco e in Via dell’Artigliere, e ci si chiedeva a chi appartenessero. Rapelli osserva che presso il primo v’era probabilmente il cimitero dei frati di S. Francesco da Paola, e nella seconda si ebbe dal 1599 al 1755 il cimitero ebraico di Verona.
187. Breve testo contenuto in Piero Piazzola, Antiche piccole “chiese” nei Lessini tra il Quattrocento e il Cinquecento, in: Lessinia: territorio e cultura, a cura di P. Piazzola e Giuseppe Rama, Curatorium Cimbricum Veronense, Verona 2002, pag. 95. È trattato qui il problema dei preti tedeschi nel Veronese; Rapelli dimostra che la loro presenza non è sempre indice che la popolazione locale sia cimbra.
188. Comunicazione personale riportata in Enzo Caffarelli, Prospettive di analisi e di ricerca da un dizionario di cognomi tra Lombardia, Piemonte e Svizzera italiana, in RIOn n. 1, 2002, pag. 151, nota. Qui Rapelli, appoggiandosi a un’affermazione dello storico veronese ottocentesco Antonio Cartolari, attribuisce al cognome ver. Albertini il significato originario di «piccoli Alberti = ramo secondario degli Alberti di Firenze».
189. Lettera ad Ar. del 17 ott. 2002, pubblicata a pag. 21 col titolo Ponte: inventato dall’inglese Bailey. L’autore corregge qui l’espressione — ricorrente nel giornale — “ponte Baley”, specificando che si tratta invece di “ponte Bailey”, dal nome del suo inventore, l’ingegnere inglese Sir Donald Coleman Bailey.
190. L’origine della lingua cimbra – in “Cimbri notizie / Tzimbar Naugaz” n. 20-21, 2002, pag. 4.
191. Un avvenimento del 1909 a Giazza – in CT n. 28, 2002, pp. 119-122.
Bondardo aveva segnalato a Rapelli una curiosa scritta a matita sul retro della copertina di una vecchia grammatica dell’alto tedesco in cui si diceva che un certo sig. Hörstel era venuto a Giazza nel 1909 per studiare il cimbro. Rapelli sospetta che l’autore della scritta fosse mons. Cappelletti.
192. Commento alla recensione da parte di Enzo Caffarelli dell’opera di Ottavio Lurati Perché ci chiamiamo cosí?, apparso nella rubrica Postille di RIOn n. 2, 2002, pp. 731-732.
Vengono fatti notare alcuni nei, nel pur magistrale lavoro del Lurati: la mancata indicazione della qualità delle “z” (sia quella sorda che quella sonora hanno lo stesso segno grafico, z), la frequente omissione dell’accento tonico (per cui non si sa dove cada in certi cognomi come p. es. Bomio), la frequente omissione del grado di apertura delle vocali e o (per cui non si sa se p. es. Losa vada pronunciato Lòsa o Lósa). Dal punto di vista delle etimologie, Rapelli propone di vedere in Perabò non già un “pela-buoi” ma un “para-buoi”, corrispondente al Menaboi di Modena del XII secolo.
193. Lettera ad Ar. del 29 genn. 2003, pubblicata a pag. 21 col titolo Strade: mantenere i nomi storici. L’autore si ricollega a un’iniziativa del prof. Scola Gagliardi volta a ripristinare certi nomi storici di vie di Bovolone, e propone di mantenere il piú possibile i toponimi in uso tra la gente. Egli si rammarica, per esempio, del fatto che nella toponomastica ufficiale di Verona si sia tralasciata la popolarissima Giarina. Inoltre, a dimostrazione dell’assurdità delle denominazioni ufficiali, l’autore cita la lunga strada che da Porta Vescovo va a S. Michele (parallela alla statale per Vicenza), e che ha ben sei nomi.
194. Lettera ad Ar. del 18 giugno 2003, pubblicata a pag. 24 all’interno di un articolo intitolato Qui abitava mr. Bodilone: fu un longobardo a “battezzare” il posto. In contrasto con altre ipotesi, si propone qui l’etimologia di Bovolone dal nome di un personaggio longobardo, tale Bodilone.
Nell’articolo, solo parte della lettera fu pubblicata, e anche questa con rimaneggiamenti. Rapelli intendeva contestare un etimo proposto qualche tempo prima, che voleva la derivazione del paese da ranabòdolo, «girino».
195. Breve intervista, riportata in Ar. del 9 ottobre 2003, pag. 35, in cui Rapelli accenna ad alcune etimologie di toponimi della Bassa veronese, tra cui Bovolone, Legnago, Sanguinetto e Isola Rizza.
196. Recensione di: Paola Mura, Di due forme lessicali “cimbro”-venete, in “Saggi dialettologici in area italo-romanza”, 6ª raccolta, a cura di Maria Teresa Vigolo e Alberto Zamboni, Ist. di Scienze e Tecnologie della Cognizione del C.N.R., Sezione di Padova “Fonetica e dialettologia”, Roma 2002 – in CT n. 30, 2003, pp. 164-165.
Incidentalmente, l’autore si chiede qui quale fosse l’esatta pronuncia di una voce tredicicomunigiana che già aveva riportato nei suoi Testi cimbri (vedi sopra “Volumi”, § 2) come scherge con g palatale, «usciere incaricato dei pignoramenti», seguendo il Kranzmayer: la Mura la dà nei Sette Comuni come sièrghe.
197. Recensione di: Maria Teresa Vigolo - Fernando Zampiva, Le piante medicinali in aree veneto-cimbre vicentine e veronesi tra etnobotanica e dialettologia, in “Saggi dialettologici in area italo-romanza”, 6ª raccolta, a cura di Maria Teresa Vigolo e Alberto Zamboni, Ist. di Scienze e Tecnologie della Cognizione del C.N.R., Sezione di Padova “Fonetica e dialettologia”, Roma 2002 – in CT n. 30, 2003, pag. 165.
198. Note di toponomastica - in AA. VV., Roveredo di Guà e la sua Storia, a cura di Francesco Occhi, Roveredo di Guà (Verona) 2004, pp. 257-266.
È data qui l’etimologia di un’ottantina di toponimi moderni e antichi del piccolo comune di Roveredo di Guà, nella Bassa veronese.
199. Recensione di: Sergio Bonato, Trent’anni (Draisk jaardar, Dreizig Jahre) dell’Istituto di Cultura Cimbra, Ist. di Cult. Cimbra, Roana 2003 – in CT n. 31, 2004, pag. 166.
200. Lettera ad Ar. del 6 settembre 2004, pubblicata a pag. 13 col titolo Invasione di temibili insetti. L’autore rettifica qui la lettura della nota iscrizione che è ancora visibile all’interno dell’atrio del Tribunale, relativa a un’invasione di cavallette avvenuta nel 1542; notevole il verbo manzò «mangiarono», letto da tutti finora maro quale abbreviazione di magnaro, e invece scritto in realtà mazo con la tilde sopra la “a”. Sono ripetuti qui i concetti già espressi qui sopra nel § 23.
201. Etimologia del toponimo El Capitèl de Stémpe di Campofontana, ritenuto derivare dal mat. tëmpel «tempio», citata da Piero Piazzola in CT n. 32, 2004, pag. 44, nota.
202. Una minoranza tedesca di lingua slava – in CT n. 32, 2004, pag. 142.
In occasione dell’arrivo a Verona di una delegazione di Sòrabi, viene spiegato che si tratta di un popolo slavo della Germania orientale, dando brevi cenni sulla sua storia.
203. Riveduta la traduzione in cimbro della poesia di Andrea Oxilia Tzimbar adalar (= «Aquila cimbra»), in “Cimbri notizie”, supplemento a CT n. 32, 2004, pag. 6.
Il testo pubblicato non corrisponde, tuttavia, a quello effettivamente tradotto da Rapelli: nell’originale mancavano gli ultimi quattro versi cimbri che qui compaiono (la cui versione italiana, tra l’altro, non è quella a fronte, trovandosi nella quartina precedente).
204. Collaborazione linguistica all’opuscolo di David Conati - Guido Ruzzenenti L’osto de Verona, commedia in un atto (per circa 6500 parole), Cierre, Sommacampagna, s.d. (ma 2005).
La collaborazione è consistita nel tradurre il testo nel linguaggio di Verona degli inizi dell’Ottocento. L’osto («ristoratore; oste») è un personaggio della Verona di allora, autore — attraverso la mediazione del suo segretario, molto piú colto di lui — di un diario coprente un periodo di oltre quarant’anni tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento.
205. Lettera ad Ar. del 4 apr. 2005, pubblicata a pag. 18 col titolo Dialetto: rimane un valore culturale, ripubblicata l’11 apr. 2005 a pag. 13 col titolo Dialetto: scuola in condizioni critiche. Sullo stesso giornale, il 19 genn. 2005 era apparsa un’inchiesta relativa alla possibilità di insegnare i dialetti nei licei; Rapelli ribatte a un preside che aveva detto che il dialetto non ha nessun valore culturale.
I concetti qui esposti sono press’a poco gli stessi di un’altra lettera (si veda qui sopra il § 176), e anche il preside è la stessa persona. Stavolta, però, la lettera viene riportata integralmente; in essa, Rapelli si chiede che cosa resterebbe della lingua ufficiale se ne venissero tolte le espressioni derivate dai dialetti, e riporta a scopo esemplificativo 60 tra voci e modi di dire penetrati nell’italiano dai dialetti. La seconda versione diverge lievemente dalla prima, dovuto al fatto che Rapelli inviò al giornale due lettere successive sull’argomento (credendo che la prima fosse andata perduta…).
206. Intervista in Ar. del 25 maggio 2005 (a cura di e. cerp. = Emma Cerpelloni), pubblicata a pag. 61 col titolo Salizzole, il trigesimo della scomparsa di monsignor Corrà: Sennen, il nome del vescovo ricorda un martire persiano.
Un vescovo nativo di Salizzole, Sennen Corrà (1924-2005), aveva un nome inconsueto; qui ne viene data l’etimologia, da Sennen martire persiano sotto Decio o piú probabilmente Diocleziano.
207. Recensione di: Stefano Vassere, Bellinzona al centro: viaggio illustrato tra nomi di luogo e storia, Salvioni Edizioni / Municipio della Città di Bellinzona / Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona 2004, pp. 174 – in RIOn 2, 2005, pp. 487-489.
208. Lettera ad Ar. del 25 nov. 2005, pubblicata a pag. 46 col titolo Bandiere: superare ogni fanatismo.
Sulla stampa era apparsa la notizia che alcune delegazioni vorrebbero proporre all’ONU la sostituzione dell’emblema della Croce Rossa, ritenuto simbolo “cristiano” per la croce che vi è raffigurata; Rapelli dimostra che in realtà l’emblema nacque dalla bandiera svizzera (in onore del fondatore della CRI, lo svizzero Jean-Henri Dunant), invertendone i colori.
209. Il dialetto cimbro (tauc’): lingua ancora parlata a Giazza ed un tempo in tutta la Lessinia centro-orientale – in Lessinia, a cura di Paola Bodini - Gaetano Bonazzi - Marco Comencini - Piero Corsi - Maurizio Delibori - Gianmarco Lazzarin - Fiammetta Serego Alighieri - Massimo Tridapali, CTG Lessinia, Bosco Chiesanuova 2005, pp. 433-435.
Il titolo fu scelto dal coordinatore dell’opera, M. Delibori (donde l’incongruenza dialetto-lingua); l’articolo è inficiato da alcuni refusi, non avendo potuto l’autore rivedere le bozze.
210. Breve brano in cimbro (4 righe) pronunciato a Benediktbeuern il 22-9-2005, assieme alla sua traduzione in tedesco, come saluto di un Veronese agli abitanti della zona; apparso in Gemeinde-Nachrichten aus Benediktbeuern (un giornalino comunale di Benediktbeuern), febbraio 2006, pag. 3, e ripubblicato in CT 35, 2006, pp. 153-154.
211. Segnalazione di: Massimo Pittau, Dizionario della lingua etrusca, Sassari 2005 – in RIOn 1, 2006, pp. 285-286.
L’articoletto comparve senza firma, facendo parte del materiale curato dalla redazione della rivista.
212. Note storiche – in Sport Events 1, febbr. 2006, semestrale dedicato alla gara sportiva Lessinia Legend (giugno 2006).
L’articolo occupa 4 pagine (non numerate); sono riportate qui alcune note storiche ed etimologiche di 23 località quasi tutte appartenenti alla Lessinia.
213. Le circostanze che favorirono l’arrivo dei primi Cimbri — Storia generale dei Cimbri — Storia dei XIII Comuni Veronesi, tre interviste curate da Katia Teboni e mandate in onda sull’emittente locale Radio Cimbri Lessinia (= RCL, sulla frequenza di 95,9 FM) in vari momenti a partire dal marzo 2006.
214. Segnalazione di: Giovanni Tassoni, Il gioco della signora: la strega, il rito, la magia (scritti inediti e rari a cura di Alberto Castaldini), Tre Lune Edizioni, Mantova 2005, pp. 104 – in CT 35, 2006, pag. 154.
215. Lettera a “La nuova Voce Giuliana” (quindicinale di Trieste) del 1° sett. 2006, pubblicata a pag. 5 senza titolo.
V’è qui riferimento a un articolo del direttore della rivista apparso il 16 luglio, nel quale questi si doleva del fatto che l’Istria fosse sconosciuta al grande pubblico italiano. In appoggio a questa affermazione, Rapelli riporta le sue esperienze personali, dalle quali risulta come molti turisti italiani parlino delle loro vacanze in Croazia (non in Istria), citando i nomi sloveni o croati dei paesi, non quelli italiani. La lettera termina addebitando questa situazione non a una presa di posizione politica, ma semplicemente alla diffusa ignoranza della geografia e della storia.
216. Materiale per un’intervista apparsa in “Verona fedele” del 3-12-2006, pag. 16.
L’autore dell’intervista, Lino Cattabianchi, riporta due etimologie raccolte da Rapelli, una relativa al toponimo la Frizzolana (nome medievale di Bosco Chiesanuova, da un antico Foroiuliana), l’altra relativa al cognome Pallavicini, alla cui base è il nome personale piemontese medievale Paravisín = «Paradisino».
217. Eligio Faggioni, poeta di Giazza – in CT 36, 2006, pp. 145-152.
L’articolo vuole ricordare una singolare figura di poeta-contadino e i suoi rapporti con l’autore, oltre che con altre persone del Curatorium. In appendice sono riportate quattro sue poesie relative ai mesi dell’anno da gennaio ad aprile, tratte dai Testi cimbri (§ 2 dei “Volumi”).
218. Un francescano sull’Altopiano dei Sette Comuni – in CT 37, 2007, pp. 55-58.
È delineato qui un piccolo ritratto di una singolare figura di frate francescano, Ildefonso Corrà, di 79 anni. Egli esercitò la sua missione per sette anni sull’Altopiano di Asiago, dove imparò la lingua locale per poter confessare i pastori cimbri.
219. Lettera ad Ar. del 28 novembre 2007 pubblicata a pag. 19 col titolo Lingua cimbra: “Schuane” e non “Shuame”.
Era apparsa la notizia che una alpaca di nome Shuame = «bella» aveva dato alla luce due piccoli a Giazza; l’autore fa notare che “bella” è veramente in cimbro schuane.
220. Lettera ad Ar. del 7 dicembre 2007 pubblicata a pag. 23 col titolo Il nome risale ai longobardi.
La lettera contestava l’etimologia, comunicata dal direttore del giornale a un lettore il 28 novembre, di Piazza Brà, fatta derivare dal tedesco breit «largo». Rapelli fa notare che viene invece dal longobardo braida «campagna, luogo spazioso».
221. Piccole esperienze di contatti coi Cimbri – in CT 38, 2007, pp. 79-84.
Sono illustrati qui i contatti avuti dall’autore nel corso degli anni con varie persone di Giazza; importante, in particolare, l’ultimo, quando l’autore incontrò il Cele (Celestino Lucchi) e parlò con lui usando unicamente il cimbro.
222. La festa dei Cimbri del Cansiglio – in CT 38, 2007, pag. 156.
Si accenna qui a una piccola conferenza tenuta dall’autore alla Festa dei Cimbri del Cansiglio del 4-5 agosto 2007, al termine della quale Rapelli raccomandò ai responsabili di far studiare il dialetto veneto locale per accertare le voci cimbre che in esso sono sicuramente sopravvissute.
223. Le lingue nel mondo – in Tracce di Homo, Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova, anno scolastico 2007-2008, pp. 174-177.
Adattamento di una lezione tenuta dall’autore, con notevoli rifacimenti da parte dei curatori del volume (la cartina a pag. 175 è dell’autore).
224. Il Palio di Verona – articolo inserito in una cartella consegnata il 2-2-2008 ai partecipanti alla presentazione della “Corsa del Palio Verde” di Verona e ripubblicato in Mar. del marzo 2008.
Viene fatta la storia del Palio, istituito probabilmente nel 1208 (ben otto secoli fa, e quindi qualificabile come la piú antica corsa podistica del mondo).
225. Cognomi del Veronese – in Il Veneto e la cultura contadina e popolare fra passato e presente, a cura di Mario Gecchele, Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona 2008, pp. 127-140.
Testo di una conferenza divulgativa tenuta all’Istituto Campostrini di Verona alla fine del 2006.
226. Intervista apparsa in Ar. del 29 aprile 2008, a pag. 35 (in un articolo dal titolo Lucidalba, la centenaria con il nome quasi unico).
Qui l’autore parla del nome femminile Lucidalba, documentato tra la Bassa veronese e l’Emilia già dal 1729, derivandolo da un letterario luci d’alba a indicare una bimba nata di primo mattino, “alle luci dell’alba” (l’etimologia è stata riportata dal giornalista solo parzialmente).
227. Testi per il sito Internet www.cimbri.it, luglio 2008.
Si tratta di sette testi esplicativi dai seguenti titoli: 1) Chi sono i Cimbri?; 2) Profilo storico; 3) Insediamenti cimbri; 4) L’origine del cimbro; 5) Il cimbro oggi; 6) La toponomastica cimbra; 7) Le isole linguistiche cimbre.
228. Lettera ad Ar. del 19 agosto 2008 pubblicata a pag. 19 col titolo Istria e Dalmazia: un divieto inspiegabile.
L’autore fa notare come sia assurdo che i toponimi dell’Istria e della Dalmazia vengano sempre, inspiegabilmente, riportati nella versione croata e mai in quella italiana: Rijeka invece di Fiume, Krk invece di Veglia, ecc.
229. Lettera ad Ar. del 12 novembre 2008 pubblicata a pag. 21 col titolo Curiosità: i nomi delle località.
Viene fatto notare come sia assurdo togliere l’articolo da toponimi quali Il Chievo, Il Vago, Le Golosine, Le Matozze. L’articolo ha qui una lunga tradizione storica, come accade anche per le città di La Spezia, L’Aquila, Il Cairo, L’Aja.
230. Ricordo di Piero Piazzola (1924-2008), senza titolo – in CT 40, 2008, pp. 16-18.
Una rievocazione di come l’autore conobbe lo stimato maestro di Campofontana, uno dei fondatori del Curatorium Cimbricum Veronense.
231. Il Palio di Verona – in “Il Caffè” 45/5, 7 marzo 2009, pp. 3-4 (visibile in www.sportcaffe.it).
È ripreso qui, e ampliato, l’articolo di cui qui sopra al § 224. Il presente testo fu letto in pubblico alla riunione del Mombocar del 21-2-2009, istitutiva della II edizione del Palio del Drappo Verde di Verona.
232. Il magico mondo delle streghe, Terzo (Alessandria) 2009 – traduzione dallo spagnolo (titolo originale El mágico mundo de las brujas, Ediciones Continente, Buenos Aires 2004).
233. Il magico mondo dei folletti, Terzo (Alessandria) 2009 – traduzione dallo spagnolo (titolo originale El mágico mundo de los duendes, Ediciones Continente, Buenos Aires 2004).
234. Il magico mondo dei maghi, Terzo (Alessandria) 2009 – traduzione dallo spagnolo (titolo originale El mágico mundo de los magos, Ediciones Continente, Buenos Aires 2004).
235. Lettera ad Ar. del 15 maggio 2009 pubblicata a pag. 21 col titolo Buso del gato e bugigattolo.
Trattando dell’etimo del vicolo Buso del Gato di Soave, l’autore lo deriva dalla voce ver. bosegàto o busegàto significante « budello », una cui variante busegàtolo « pertugio » è attestata nel veronese dell’inizio dell’Ottocento (donde l’ital. bugigattolo). Quindi, il « buco del gatto » attuale rappresenta una lieve forzatura del significato originario.
236. Lettera ad Ar. del 23 maggio 2009 pubblicata a pag. 23 col titolo Toponimi: Massacanà è l’acciottolato; ripubblicata in Ar. del 30 maggio 2009 a pag. 25 col titolo Massacanà: pavimentazione a ciottoli.
Discutendo di un paio di toponimi, la Massacanà di S. Maria in Stelle e di S. Pietro di Lavagno, l’autore fa notare che la voce significa appunto « acciottolato », in contrasto con un’opinione espressa da altri che si tratti di alterazione dell’ingl. macadam. Una settimana dopo la lettera ricompare con piccole modifiche.
237. Le riviste che precedettero “Cimbri/Tzimbar” – in CT n. 41, 2009, pp. 21-22.
Viene data qui una breve storia delle testate che precedettero “Cimbri/Tzimbar”, la prima delle quali — un giornalino ciclostilato — apparve nel 1960.
238. Segnalazione di: Bruno Schweizer, Zimbrische Gesamtgrammatik: vergleichende Darstellung der zimbrischen Dialekte, a cura di James R. Dow, Stoccarda 2008, pp. 972 – in CT n. 41, 2009, pag. 84.
239. ’Ndo steto? - Mi? Al Céo! (Dove abiti? - Io? Al Chievo!) – in “Testimonianze”: Lavori a Chievo nel 1900 (Il commercio, le botteghe - L’industria, le imprese), vol. II, Parte II, Centro d’Incontro e di Aggregazione Chievo, Verona 2009, pag. 5.
Breve articolo in cui si sottolinea l’importanza di preservare l’articolo nel nome del paesino, oggi sobborgo di Verona (che è propriamente il Chievo, esattamente come si dice Il Cairo, La Mecca, La Spezia, L’Aquila, e presso Verona Il Saval, Il Basson, Il Basso Acquar, ecc.).
240. Lettera ad Ar. del 17 novembre 2009 pubblicata a pag. 21 col titolo Storie di paese: l’oste e il crocefisso.
È riportato qui un fatto autentico verificatosi in un paese del Veronese (di cui non viene fornito il nome). Qualche anno fa vi fu un processo intentato da tale Abel Smith perché venissero rimossi i crocefissi dalle scuole: in questo paese v’era un bar di fedelissimi comunisti che, prima sprovvisto del crocefisso, lo volle mettere in bella vista per reazione. Una vicenda alla don Camillo e Peppone…
241. Lettera ad Ar. del 28 novembre 2009 pubblicata a pag. 25 col titolo Modi di dire: chi fa davvero il “portoghese”.
Si riporta qui una recente, acuta etimologia del detto fare il portoghese « entrare in un locale o salire su un treno (o su un bus) senza pagare », secondo la quale il Portogallo non c’entra per nulla.
242. Recensione di: Ondina Lusa - Marino Bonifacio, Le perle del nostro dialetto, II volume, Pirano 2010, pp. 312 – in “La voce del popolo” (Fiume) n. 178, 4 agosto 2010, pp. 20-21.
243. In memoriam: Maria Hornung – in CT n. 44, 2010, pp. 53-56.
Una biografia della linguista viennese che tanto si è occupata delle isole linguistiche tedesche formatesi a partire dall’Austria, con una bibliografia dei suoi scritti più notevoli.
244. Gran Massaro dei Cimbri 2010, prof. Ezio Filippi, geografo e storico della Lessinia – in CT n. 44, 2010, pp. 103-104.
Articoletto sulla nomina onorifica a Gran Massaro dei Cimbri di un profondo conoscitore della Lessinia, comprendente una bibliografia dei suoi scritti più notevoli sulla Lessinia stessa.
245. Lettera ad Ar. del 29 dicembre 2010 pubblicata a pag. 18 col titolo Il solstizio di Santa Lucia.
Contestando una precedente ipotesi, l’autore afferma che il detto veronese a santa Lússia ’na pónta de úcia era pienamente giustificato prima del 1582, perché allora, effettivamente, il solstizio d’inverno cadeva il 13 dicembre. Con la riforma gregoriana, a partire dal 1582 il solstizio venne a cadere, come oggi, il 22 dicembre, giorno di s. Demetrio.
246. Lettera al quindicinale di Trieste “La nuova Voce Giuliana” del 16 marzo 2011, pubblicata a pag. 3 col titolo L’Alto Adige e l’Unità d’Italia.
In appoggio all’affermazione del direttore della rivista che nel 1947 non venne tenuta in nessun conto la volontà della popolazione italiana dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia di restare con l’Italia, l’autore fa presente che quasi mai gli accordi internazionali rispettarono la volontà popolare. Nel 1860, cosí, il Regno di Sardegna cedette alla Francia non solo la Savoia, di lingua e cultura francesi, ma anche l’italiana Nizza, ciò che provocò l’esodo di varie migliaia di famiglie verso l’Italia. Contemporaneamente, l’autore si dichiara d’accordo col presidente altoatesino Durnwalder quando dice che non si sente di festeggiare l’Unità d’Italia, essendo stata la popolazione tedesca strappata all’Austria alla quale era legata da cinque secoli di storia e cultura.
247. Lettera ad Ar. del 13 aprile 2011 pubblicata a pag. 25 col titolo Vicoli: l’origine è nel pomo d’oro.
Lettera di risposta a una lettrice che chiedeva perché un vicolo di Verona avesse due targhe stradali diverse: Vicolo Pomodoro e Vicolo Pomo d’Oro. L’autore sostiene che all’origine è il nome di una farmacia, all’insegna del pomo d’oro (con riferimento al Giardino delle Esperidi o alla mela consegnata da Paride alla dea Afrodite); quindi, assolutamente non c’entra il pomodoro ortaggio.
248. Lettera ad Ar. del 7 luglio 2011 pubblicata a pag. 17 col titolo Gheddafi: traditori, non ratti.
Viene contestata qui una falsa traduzione: il giornale aveva riportato la notizia che il figlio di Gheddafi aveva detto che mai i “ratti” di Bengasi avrebbero assunto il governo della Libia. In realtà, le agenzie internazionali avevano parlato dei rats di Bengasi; qui non c’entrano i ratti, o grossi topi, ma i «traditori, voltagabbana, venduti al nemico».
249. Prefazione al volume di Marino Bonifacio Cognomi di Capodistria, Pirano 2011, pp. 7-10.
250. Traduzione nel cimbro tredicicomunigiano del bando del concorso Premio Tönle Bintarn 2011, istituito per premiare un elaborato prodotto in uno dei linguaggi cimbri (la premiazione avvenne il 17 dicembre 2011 a Luserna).
251. Qualcosa su San Giovanni Lupatoto – articolo di due pagine inserito in una cartella consegnata ai partecipanti alla 17ª edizione della “Lupatotissima” (24-25 settembre 2011), una gara suddivisa in sei specialità podistiche.
Sono trattate qui l’etimologia di S. Giovanni Lupatoto e la storia della Pace di Paquara, stipulata nel 1233 nei pressi del paese tra molte fazioni della Valpadana.
252. Lettera ad Ar. del 12 aprile 2012 pubblicata a pag. 25 col titolo Fascismo: sono caduti gli steccati.
Rapelli commenta un libro biografico (trattato in precedenza nel giornale) dello scrittore triestino di lingua slovena Boris Pahor, nel quale Pahor chiede che si dica la verità storica sul conflitto tra italiani e slavi, riconducendo al fascismo tutti i mali accaduti ai confini orientali d’Italia dopo il 1943. Rapelli sostiene che la verità storica deve essere completa, non parziale, e ricorda l’accanita politica antiitaliana instaurata dagli austriaci dopo la perdita della Lombardia nel 1859 e ancora di piú dopo la perdita del Veneto nel 1866, attuata soprattutto col fomentare il nazionalismo slavo.
253. Lettera ad Ar. del 9 giugno 2012 pubblicata a pag. 25 col titolo Sri Lanka: Singalesi non cingalesi.
L’autore critica il malvezzo di definire Cingalesi gli abitanti di maggioranza dello Sri Lanka, mentre — come registrano tutte le principali fonti scientifiche — si tratta di Singalesi.
254. Introduzione alla ristampa, in Ondina Lusa - Marino Bonifacio, Le perle del nostro dialetto (II volume), Pirano 2012, pp. 7-8.
255. Il Gran Massaro dei Cimbri 2012 – in CT 47, 2012, pp. 47-51.
Un resoconto della nomina a “Gran Massaro” per il 2012 del prof. Ermenegildo Bidese, linguista e germanista esperto in particolare del cimbro. Alla S. Messa che venne tenuta, venne letto il brano del Vangelo di s. Marco 5, 21-43 (con l’emorroissa e la bambina morta), nella versione in cimbro effettuata da Rapelli. La rivista ospita questa versione assieme alla sua traduzione letterale in italiano.
256. Cimbri scandinavi e Cimbri italiani: sono lo stesso popolo?
Testo non apparso a stampa, consegnato ai partecipanti agli incontri dell’Università della Terza Età di Bosco Chiesanuova nell’estate del 2012. La risposta alla domanda è, naturalmente, che si tratta di due popoli ben diversi: l’uno, disfatto ai Campi Raudii nel 101 a.C., era di origine scandinava; l’altro, come è noto, è di origine tedesca.
257. Tedeschi sui Lessini: giunsero prima del 1287?
Testo non apparso a stampa, consegnato ai partecipanti agli incontri dell’Università della Terza Età di Bosco Chiesanuova nell’estate del 2013. La risposta alla domanda è che non sono attestati Tedeschi prima del 1287: i nomi germanici che vi troviamo nel Medioevo centrale sono comuni a gran parte d’Italia, ma sono — appunto — germanici (quindi longobardi, gotici, ecc.), non tedeschi nel senso del termine.
258. Un giorno d’estate a Camposilvano — in “La Lessinia ieri oggi domani”, n. 36, 2013, pp. 29-31.
È rievocato qui un incontro tra Rapelli e Attilio Benetti a casa di quest’ultimo, a Camposilvano. Attilio, noto comunemente come el Tílio, fu internazionalmente riconosciuto come uno dei massimi esperti di ammoniti, ma conservava anche ricordi casalinghi dell’antica parlata cimbra.
259. Recensione di: Massimo Pittau, Lessico della lingua etrusca: appellativi antroponimi toponimi, “Quaderni Italiani di RIOn” 5, Roma 2013, pp. VIII + 232 – in RIOn 2, 2013, pp. 720-721.
260. Recensione di: Lydia Flöss, I nomi di luogo di Fierozzo/Vlarotz, Frassilongo/Garait, Palú del Fersina/Palai en Bersntol, “Studi trentini: Storia” 92, I, Trento 2013, pp. 115-154 — in RIOn 2, 2013, pp. 730-731.
261. Il latino dei primi secoli e l’etrusco: nuove ipotesi con il sostegno di toponimi e antroponimi — in RIOn 2, 2013, pp. 841-842.
Articolo redazionale basato su dati forniti dall’autore. Viene annunciata qui la prossima pubblicazione di un libro nel quale l’autore sostiene un influsso dell’etrusco sul latino dei primordi molto piú incisivo di quanto si pensasse finora. Sono proposte numerose etimologie nuove tanto del latino che dell’etrusco.
262. Segnalazione di: Matteo Siena, La città visibile: l’odonomastica di Vieste dall’Era antica ad epoca contemporanea, Vieste 2009, pp. 328 (il titolo è quello della copertina, ma il frontespizio reca La Città Visibile: la toponomastica viestana dall’età antica all’epoca contemporanea) — in RIOn 2, 2013, p. 919.
263. Lettera ad Ar. del 10 dicembre 2013 pubblicata a pag. 21 col titolo Etimologie: la rotta della Cucca.
L’autore commenta una strana etimologia fatta da tale dr. Forlati secondo cui la “Rotta della Cucca” del 589 d.C. deriverebbe il nome da una voce germanica riferita all’Organum presso S. Maria in Organo. In realtà, quella denominazione accenna a una “rotta” degli argini dell’Adige presso la località della Cucca, oggi Veronella nella Bassa veronese.
264. Lettera ad Ar. del 7 febbraio 2014 pubblicata a pag. 25 col titolo Boscarello: una famiglia, non una selva.
Un foglietto scritto in latino era stato appeso da qualcuno per protestare contro il troppo traffico nel Vicolo Boscarello di Verona; Rapelli contesta che in esso il termine Boscarello sia stato tradotto con parva silva, poiché in realtà il toponimo deriva da un antico abitante della zona di nome Biscarello.
265. Lettera ad Ar. del 2 marzo 2014 pubblicata a pag. 24 col titolo Cognomi: e se Catanía fosse in Sicilía....
A seguito di una richiesta esplicita di tale Francesco Menón, Rapelli esprime la sua opinione sul vezzo negativo di cambiare l’accentazione di tanti cognomi veneti (come il suo, abitualmente pronunciato Mènon) ma anche di tanti toponimi di tutta la penisola, e ricorda le accentazioni sbagliate della TV come per esempio Villasímius, Paulilatíno, Màcomer, Àrbatax.
266. Le vie di Verona parlano: San Zeno – in NT 52, maggio 2014, pp. 8-9.
Rassegna etimologico-storica dei toponimi del quartiere veronese di San Zeno.
267. Le vie di Verona parlano: San Zeno – in NT 52, maggio 2014, pp. 8-9.
Rassegna etimologico-storica dei toponimi del quartiere veronese di San Zeno.
268. Lettera ad Ar. del 27 maggio 2014 pubblicata a pag. 39 col titolo C’è Bardolíi e... Bardolií.
Guariente Guarienti aveva scritto una lettera al direttore tre giorni prima per sollecitare un intervento di Rapelli sulla grande differenziazione dialettale esistente nel Veronese. Rapelli conferma questo fenomeno, spiegando a mo’ di esempio che il nome di Bardolino è Bardolií nel paesino in questione, ma Bardolíi nella vicina Garda.